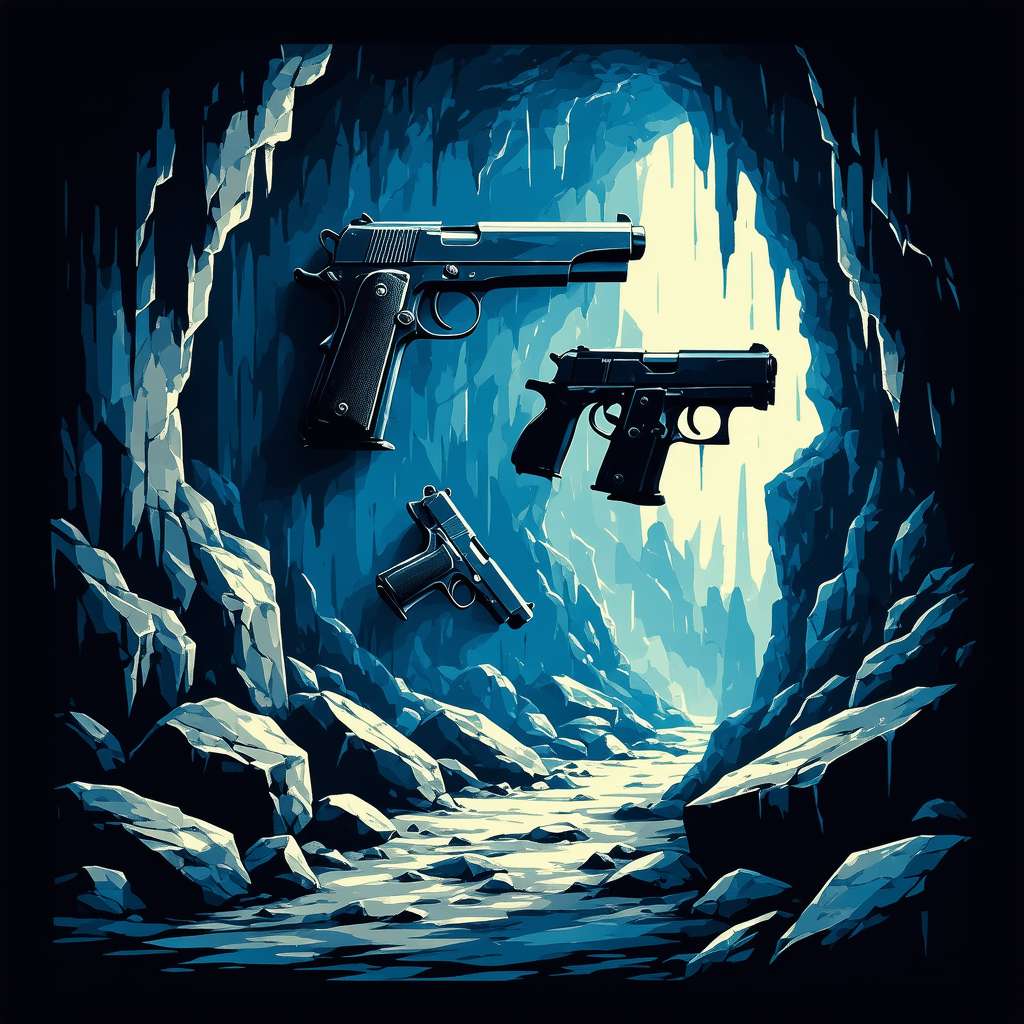E-Mail: [email protected]
- Il ghiacciaio di Solda ha subito una contrazione di 26 metri rispetto al 2024, confermando un trend decennale di ritiro di circa 20 metri all'anno.
- La superficie dei ghiacciai in Alto Adige si è quasi dimezzata tra il 1997 e il 2023, passando da 122,2 km² a 72,2 km², con una diminuzione del numero dei ghiacciai da 234 a 203.
- La recente decisione del TAR di Bolzano di bloccare l'ampliamento del comprensorio sciistico in Val Senales evidenzia la necessità di una valutazione ambientale strategica (VAS) e di una valutazione di incidenza ambientale (VIncA) prima di intraprendere progetti di sviluppo turistico in aree sensibili.
Solda: Trasformazione di un Ghiacciaio Alpino e Responsabilità Territoriali
Il ghiacciaio di Solda, sito nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, sta vivendo una metamorfosi rapida, mutando da un contesto di ghiaccio e neve a un “mare nero di detriti”. Questo avvertimento, diffuso dalla Carovana dei Ghiacciai, mette in luce una problematica stringente che impatta l’intera catena alpina e pone questioni in merito alle responsabilità nella conduzione del territorio.
La storia di un cambiamento accelerato
La Carovana dei Ghiacciai 2025 ha documentato una contrazione marcata del ghiacciaio di Solda. La misurazione ha rivelato una diminuzione di 26 metri rispetto al 2024. Questo valore conferma un trend decennale allarmante. Nell’ultimo decennio, il ghiacciaio si è ritirato in media di 20 metri all’anno. Un raffronto storico palesa la grandezza del mutamento. Nella seconda parte dell’Ottocento, il ghiacciaio si protendeva fino a valle, giungendo nell’area dove ora si trova il parcheggio della funivia. Oggi, la massa glaciale è relegata alle altitudini maggiori, in un panorama contraddistinto da detriti, smottamenti e nuovi laghi di origine glaciale.
La riduzione del ghiacciaio non è solo una questione di numeri. La trasformazione del paesaggio ha conseguenze dirette sull’ambiente alpino e sulla sua biodiversità. Le colate detritiche ricoprono il ghiaccio. Il materiale roccioso proveniente dai versanti montuosi viene trasportato a valle. Contemporaneamente, si assiste alla formazione di nuovi ecosistemi nelle aree liberate dal ghiaccio. La vegetazione colonizza gli spazi precedentemente occupati dalla massa glaciale. Questi cambiamenti, sebbene naturali, avvengono a una velocità senza precedenti, mettendo a rischio la stabilità dell’ambiente alpino.
Gli esperti del settore sottolineano l’importanza di monitorare non solo la superficie e il volume dei ghiacciai, ma anche l’evoluzione del paesaggio alpino nel suo complesso. Solo attraverso una comprensione approfondita dei processi in atto è possibile valutare i rischi potenziali e adottare strategie di gestione del territorio efficaci. Il monitoraggio costante è fondamentale per prevedere i cambiamenti futuri e per proteggere le risorse naturali delle Alpi.
La perdita di superficie glaciale è un indicatore chiave dello stato di salute dell’ambiente alpino. Dal 1997 al 2023, la superficie dei ghiacciai in Alto Adige si è quasi dimezzata. Si è passati da 122,2 km² a 72,2 km². Parallelamente, si è registrata una diminuzione del numero dei ghiacciai, da 234 a 203. In contrasto, il numero delle placche glaciali è aumentato, passando da 325 a 729. Questo fenomeno indica una frammentazione dei ghiacciai, con la formazione di piccole masse di ghiaccio isolate. La frammentazione rende i ghiacciai più vulnerabili all’aumento delle temperature e accelera il processo di fusione. È essenziale affrontare le cause di questa trasformazione e adottare misure concrete per proteggere i ghiacciai alpini.

Impatti del turismo e scelte territoriali
Un punto cruciale dell’indagine riguarda l’impatto delle attività turistiche e le scelte di gestione del territorio in Alto Adige. Lo sviluppo del turismo, spesso improntato a un modello consumistico, ha contribuito al degrado dei ghiacciai? Le infrastrutture sciistiche, come gli impianti di risalita e le piste da sci, hanno accelerato il processo di fusione? Questi interrogativi richiedono un’analisi approfondita delle politiche territoriali e delle pratiche turistiche adottate nella regione.
La costruzione di infrastrutture turistiche, come le funivie, le strade e gli alberghi, può avere un impatto significativo sull’ambiente alpino. La rimozione della vegetazione, l’alterazione del suolo e la costruzione di manufatti possono destabilizzare i versanti montuosi, aumentando il rischio di frane e colate detritiche. Inoltre, l’aumento del numero di turisti può generare un maggiore inquinamento atmosferico e idrico, con conseguenze negative sulla qualità dell’aria e dell’acqua. Un turismo non pianificato, orientato al consumo di risorse, può mettere a dura prova l’equilibrio fragile dell’ecosistema alpino.
Le attività sciistiche, in particolare, possono avere un impatto diretto sui ghiacciai. La preparazione delle piste da sci richiede l’utilizzo di macchinari pesanti, che possono compattare la neve e alterare la struttura del ghiaccio. L’innevamento artificiale, sebbene possa prolungare la stagione sciistica, richiede un elevato consumo di acqua ed energia e può alterare la composizione chimica del manto nevoso. È necessario valutare attentamente i costi e i benefici delle attività sciistiche, tenendo conto degli impatti ambientali e sociali a lungo termine.
La recente decisione del TAR di Bolzano di bloccare l’ampliamento del comprensorio sciistico in Val Senales rappresenta un segnale importante. Il tribunale ha accolto il ricorso di associazioni ambientaliste, annullando la delibera della Giunta provinciale che aveva autorizzato l’ampliamento. Il progetto prevedeva interventi in una zona ad alta sensibilità ambientale. Il tribunale ha motivato la sua decisione con l’assenza della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Inoltre, ha rilevato un immotivato cambiamento di indirizzo del Comitato ambientale. Questo caso dimostra come le scelte di sviluppo turistico in montagna debbano essere attentamente valutate, tenendo conto degli impatti ambientali e sociali. L’approccio alla gestione del territorio deve essere improntato alla sostenibilità e alla tutela delle risorse naturali.
Il caso della Val Senales mette in luce un problema più ampio. Spesso, le decisioni relative allo sviluppo turistico in montagna vengono prese senza un’adeguata consultazione delle comunità locali e delle associazioni ambientaliste. Gli interessi economici prevalgono sulla tutela dell’ambiente. I processi decisionali mancano di trasparenza. È necessario un cambio di paradigma. Le comunità locali devono essere coinvolte attivamente nella pianificazione del territorio. Gli interessi ambientali devono essere presi in considerazione fin dall’inizio. I processi decisionali devono essere trasparenti e partecipativi.
La voce degli esperti
Gli esperti del settore lanciano un allarme sulla trasformazione del paesaggio alpino. Vanda Bonardo, responsabile nazionale delle Alpi per Legambiente e presidente di Cipra Italia, fa notare che “sotto i nostri occhi il paesaggio glaciale alpino cambia: i ghiacciai arretrano, spariscono servizi ecosistemici e ne emergono di nuovi”. Questa trasformazione porta rischi crescenti, in quota e a valle. È necessaria una maggiore attenzione e un monitoraggio. Bisogna ripensare un modello di fruizione turistica della montagna. Il turismo del futuro dovrà fondarsi su un rapporto sostenibile tra uomo e natura.
Marco Giardino, vicepresidente della Fondazione glaciologica italiana e docente dell’Università di Torino, e Pietro Bruschi, presidente del Servizio glaciologico Cai Alto Adige, evidenziano come la deglaciazione in Alto Adige prosegua in modo diseguale nello spazio e nel tempo, ma sia sempre accompagnata da una trasformazione del paesaggio alpino. Si registrano colate detritiche. Emergono lembi di ghiaccio morto dalle morene. I rock glacier si destabilizzano. Il materiale detritico viene trasportato rapidamente verso valle. Il cambiamento del paesaggio alpino sta visibilmente accelerando.
Le parole degli esperti evidenziano l’urgenza di intervenire per proteggere i ghiacciai alpini. È necessario adottare politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Bisogna ridurre le emissioni di gas serra. Occorre promuovere l’efficienza energetica. Si devono incentivare le energie rinnovabili. Parallelamente, è necessario adattare le attività umane ai cambiamenti in atto. Bisogna proteggere le infrastrutture. Occorre gestire le risorse idriche in modo sostenibile. Si deve diversificare l’economia delle aree montane. La sfida è complessa. Richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni, delle comunità locali e dei singoli cittadini.
Gli esperti sottolineano l’importanza di un approccio integrato alla gestione del territorio alpino. Non si tratta solo di proteggere i ghiacciai. Bisogna preservare l’intero ecosistema alpino. Occorre tutelare la biodiversità. Si deve promuovere l’agricoltura sostenibile. Bisogna valorizzare il patrimonio culturale. La montagna non è solo un luogo di svago. È un ambiente fragile. Ha un valore intrinseco. È responsabilità di tutti proteggerla per le generazioni future.
Verso un futuro sostenibile per le Alpi
La trasformazione del ghiacciaio di Solda è un campanello d’allarme. Ci invita a riflettere sul nostro rapporto con la montagna. Ci spinge a interrogarci sulle nostre responsabilità. Ci incoraggia a immaginare un futuro diverso. Un futuro in cui la montagna non sia solo una risorsa da sfruttare, ma un patrimonio da proteggere. Un futuro in cui il turismo sia sostenibile. Le comunità locali siano protagoniste. L’ambiente sia al centro delle decisioni.
La strada verso un futuro sostenibile per le Alpi è ancora lunga. Richiede un cambio di mentalità. Un nuovo modello di sviluppo. Un impegno concreto da parte di tutti. Ma la sfida è possibile. Possiamo invertire la rotta. Possiamo proteggere i ghiacciai. Possiamo preservare la montagna. Possiamo garantire un futuro alle prossime generazioni.
Per raggiungere questo obiettivo, è necessario promuovere una cultura della sostenibilità. Bisogna educare i giovani al rispetto dell’ambiente. Occorre sensibilizzare i turisti sull’importanza di un comportamento responsabile. Si deve incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. È necessario promuovere il consumo di prodotti locali. Ogni piccolo gesto conta. Ogni azione può fare la differenza. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per le Alpi.
Oltre alle azioni individuali, è necessario un impegno forte da parte delle istituzioni. Bisogna adottare politiche di gestione del territorio lungimiranti. Occorre investire nella ricerca scientifica. Si devono promuovere le energie rinnovabili. Bisogna sostenere le comunità locali. La politica deve essere al servizio dell’ambiente. Le decisioni devono essere prese nell’interesse delle future generazioni. Solo così possiamo garantire un futuro sostenibile per le Alpi.
Scrivo questo articolo perché mi appassiona la montagna e penso che sia importante riflettere sul nostro rapporto con questo ambiente fragile. La montagna è un luogo di bellezza e di avventura. Ma è anche un ambiente vulnerabile. Richiede rispetto e attenzione. Dobbiamo proteggerla per le generazioni future. La montagna è un patrimonio di tutti. Non possiamo permetterci di perderla.
Nozione base di alpinismo: conoscere il terreno su cui ci si muove è fondamentale per la sicurezza in montagna. Informarsi sulle condizioni meteorologiche, sulla difficoltà dei percorsi e sulla presenza di pericoli oggettivi è essenziale per affrontare un’escursione o un’ascensione in modo responsabile. La conoscenza del territorio è la base per un’esperienza sicura e gratificante.
Nozione avanzata di alpinismo: la valutazione del rischio in montagna è un processo complesso che richiede esperienza e capacità di analisi. Non si tratta solo di valutare i pericoli oggettivi. Bisogna considerare anche le proprie capacità fisiche e tecniche, le condizioni del gruppo e le variabili ambientali. La gestione del rischio è un elemento chiave per l’alpinismo di alto livello. Richiede una costante attenzione e una grande capacità di adattamento.
Spero che questo articolo possa stimolare una riflessione personale sul nostro rapporto con la montagna. La montagna è un tesoro prezioso. Dobbiamo proteggerla con cura. Insieme, possiamo fare la differenza.
Non ho riformulato la frase evidenziata perché era una citazione testuale.